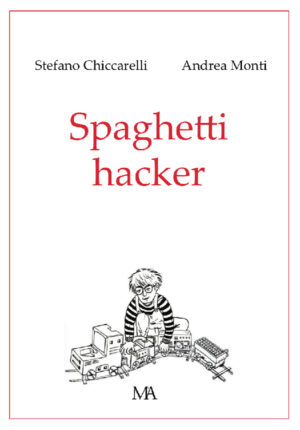
Hacker italiani?
Pescara, 26 luglio 1996: si era appena conclusa la seconda edizione de “Lo Hacker e il magistrato”. Alla fine, dopo le azioni di hacking, dopo il dibattito con magistrati, forze dell’ordine, avvocati, giornalisti e docenti universitari, svuotati dall’improvviso scomparire della tensione che accompagna iniziative del genere e dall’afa estiva tentammo un bilancio dell’iniziativa. Aveva riscosso un buon successo e da più parti giunsero richieste per avere copie degli atti o repliche dell’incontro o ancora approfondimenti sugli aspetti culturali e tecnici. L’idea di pubblicare i risultati di quelle conversazioni estive (giunte alla terza edizione) non ci era mai passata per la testa, ma dopo le sollecitazioni ricevute si decise di provare a fare qualcosa.
Da subito, ci rendemmo conto che le relazioni sulle quali si stava lavorando avrebbero richiesto pesanti integrazioni, per evitare che il lettore perdesse la bussola in mezzo a un territorio (sicuramente non virtuale) di certo sconosciuto ai più.
Nello stesso tempo, dover mettere nero su bianco fatti, tecniche e diatribe giuridiche richiese necessariamente la formulazione di un’ipotesi di lavoro, un filo rosso che avrebbe dovuto (col)legare millenni di tempo macchina trascorsi in soli quindici anni di vita biologica.
Il punto di partenza non poteva che essere una domanda: come si è sviluppato lo hacking in Italia? Ovviamente non era ragionevole pensare che di punto in bianco – a partire dal 1993 – una partenogenesi digitale avesse prodotto tante nuove entità. Doveva esserci altro, e la risposta non poteva che essere celata nel nostro passato, tanto prossimo da non avere mai provocato o richiesto una sistematizzazione.
Apparve chiaro quasi subito che l’America c’entrava poco o nulla. Prima dei contatti fra i due universi (ma anche con il resto d’Europa, particolarmente vitale quella del Nord) resi possibili dalle nascenti reti di trasmissione dati, si era già formato un nucleo (inconsapevolmente) dotato, per usare una parola forte e retrò, addirittura di un’ideologia che nel quasi totale isolamento geografico e culturale rivelò singolari analogie con modelli omologhi d’oltreoceano, ma anche caratteristiche assolutamente originali.
Posto che il fenomeno si manifestava con sue proprie caratteristiche, era evidente che utilizzare la parola hacker per classificare gli appassionati italiani era da un lato improprio e dall’altro impreciso; si doveva trovare un nome che meglio rispondesse alla realtà effettuale. La scelta è caduta su “smanettoni”, un termine che definisce una forma – il rapporto con un’attività – e che descrive bene i comportamenti e la “filosofia” di un appassionato contemporaneamente “più” e “meno” di un professionista.
Smanettoni, dunque… ma criminali! Per quanto ci sforzassimo, nonostante gli articoli di giornale, le dichiarazioni di questo o quel (perfettamente ignoto) “superesperto” che pontificavano su gruppi di terrorismo informatico, di pericolo per la sicurezza della nazione e altre calamità del genere, non riuscivamo – allora come ora – a percepire la reale portata, per non dire esistenza, di tutto questo. Certo forme di criminalità al silicio ne sono sempre esistite, ma nelle cronache più serie e nei testi meglio documentati emerge chiaramente che i responsabili delle azioni illegali erano quasi sempre dipendenti infedeli o delinquenti comuni che invece della lancia termica utilizzavano qualche chilo di ferraglia per intercettare i PIN dei bancomat. Cosa c’entrano gli smanettoni con tutto questo?
Giorno dopo giorno, la materia che stavamo plasmando cambiava forma e quindi, sostanza: dal semplice coordinare gli interventi di un convegno si stava trasformando in un progetto più ampio in grado di fornire una chiave di lettura – una delle tante possibili – di un mondo che in realtà è tutto fuorché nuovo, nel quale trovano asilo tutti quelli accomunati dalla passione per il “fare”: musica, meccanica, cultura, computer… strumenti diversi per un fine comune.
Volontariamente – e con l’eccezione delle poche righe che seguono – abbiamo scelto di non parlare degli hacker americani, sui quali è stato già detto moltissimo (anche a sproposito) i cui comportamenti e modelli vengono pedissequamente applicati anche al di qua del mare. D’altra parte, storicamente il concetto (e il termine) hacking nasce in un contesto ben specifico che non è possibile ignorare.
Il fenomeno americano dal TMRC a Mitnick
È tutta colpa dei trenini. Pochi lo sanno, ma è veramente tutta colpa dei trenini se oggi esistono gli hacker. Verso la fine degli anni Cinquanta alcuni studenti del Massachusetts Institute of Technology, uniti dalla passione per il modellismo, avevano fondato il Tech Model Railroad Club (TMRC). Si trattava di un club molto particolare che non si limitava a costruire motrici, vagoni e stazioni, ma si preoccupava anche di farli funzionare sul serio.
Per questo motivo fra i membri del club non c’erano solo quelli che si occupavano di costruire delle riproduzioni fedeli delle macchine e plastici sofisticati; qualcuno pensava anche a farli muovere progettando e realizzando una rete ferroviaria in miniatura perfettamente funzionante.
La complessità del sistema che aumentava progressivamente poneva agli studenti problemi sempre maggiori: trovare i pezzi, far funzionare insieme apparecchiature che non avevano nulla in comune, controllare da un unico punto l’intera rete ferroviaria. Era inevitabile che in una situazione di questo tipo le cose prendessero una certa piega… fu così che, quasi inconsapevolmente, gli hacker del MIT posero le basi di un fenomeno destinato a diffondersi in tutto il mondo.
Dalla prima generazione di hacker – siamo nel 1960 – animata dall’utopia di INFORMATION WANT TO BE FREE e dalla convinzione che la tecnologia dovesse essere diffusa in ogni ambito, si passa alla seconda, totalmente differente ma – è un paradosso – uguale. È il periodo degli homebrewer, dei maghi dell’hardware il cui progetto culturale era provocare lo sviluppo dell’informatica rendendo libere le architetture delle macchine, cioè i criteri e le specifiche tecniche per realizzarle. Appartengono a questo mondo Jobs & Wozniak, i creatori della Apple Computer e John Draper aka Captain Crunch, l’uomo passato alla storia per essere stato il padre delle blue box. È solo negli anni Ottanta che lo hacking comincia ad affacciarsi in Europa con la terza generazione che si occupa essenzialmente di videogame… Nessun fine ideologico, solo ragazzotti in cerca di denaro facile.
L’ulteriore onda, quella degli anni novanta, segna un ritorno al passato. Lo hacking torna a essere fine a se stesso, manifestazione di virtuosismo digitale con due differenze: ora gli hacker possono avere tutta la tecnologia che desiderano a basso costo; ora gli hacker non sono più solamente studenti ingenui o programmatori disadattati ma geniali. Nella comunità si è insinuato anche chi utilizza la conoscenza per recare danno.
Questa circostanza caratterizza molto negativamente il fenomeno dello hacking che sempre più spesso – complice un’informazione parziale e frettolosa – viene ingiustamente assimilato a fenomeni di pseudo-criminalità, mentre altrove (banche, assicurazioni, pubblica amministrazione) e per mezzo ad esempio di (ex) dipendenti si consumano eventi realmente pericolosi per la collettività.
Spaghetti hacker
In questa prospettiva anche l’Italia del computer ha avuto i propri capri espiatori. A partire dal 1992 l’approvazione di leggi perverse (come quella sulla tutela del software) o confuse e incomplete (come quella sui computer crime) ha dato l’avvio a diverse operazioni di polizia che in molti casi si sono risolte – nelle rare situazioni in cui sono stati celebrati i processi – con un nulla di fatto (assoluzioni o richieste di archiviazione) ma con pesanti violazioni dei diritti civili (sequestri arbitrari ed esagerati, metodi di indagine fortemente discutibili).
Invece di occuparsi dei veri delinquenti digitali, l’attenzione degli inquirenti si è focalizzata il più delle volte su innocui smanettoni privi di pericolosità sociale, fenomeno autoctono e solo incidentalmente collegato o collegabile allo hacking di oltreoceano.
Lo sviluppo di una cultura digitale condivisa e diffusa passa – in Italia – per canali molto diversi da quelli che hanno consentito la nascita del fenomeno americano. Basti pensare che mentre i primi hacker erano degli studenti o ricercatori di prestigiose università statunitensi (MIT in testa) dalle nostre parti tutto è cominciato – trent’anni dopo – con l’arrivo dei primi computer-giocattolo come i Commodore 64 o ZXSpectrum.
Ma insomma, esistono gli hacker italiani? Probabilmente no, certamente non nel senso primigenio della parola. Molti, ispirandosi a quel mondo, cercano di replicarne comportamenti o di mutuarne ideologie, ma in concreto “veri” hacker da noi non ce ne sono stati, almeno fino agli anni novanta. Il nostro ciberspazio era popolato nella stragrande maggioranza dei casi di abili imitatori – lamer in gergo ma il termine non descrive esattamente lo stato dei fatti – che per quanto bravi sono lontani anni luce dagli USA. Il che non è necessariamente un male, visto che si tratta di un movimento con delle caratteristiche autonome – e non criminali – che esprime probabilmente una “via italiana” nel complesso tema del rapporto con la tecnologia e con il futuro fatta di gioco, intelligenza e di passione per le macchine.
Forse, quando si smetterà di guardare i computer con la lente deformata dell’ignoranza e del sensazionalismo, si potrà cominciare a riflettere nitidamente sulle nuove generazioni di smanettoni italiani… gli Spaghetti Hacker.
